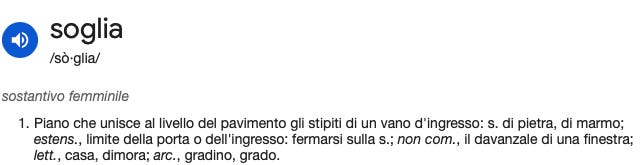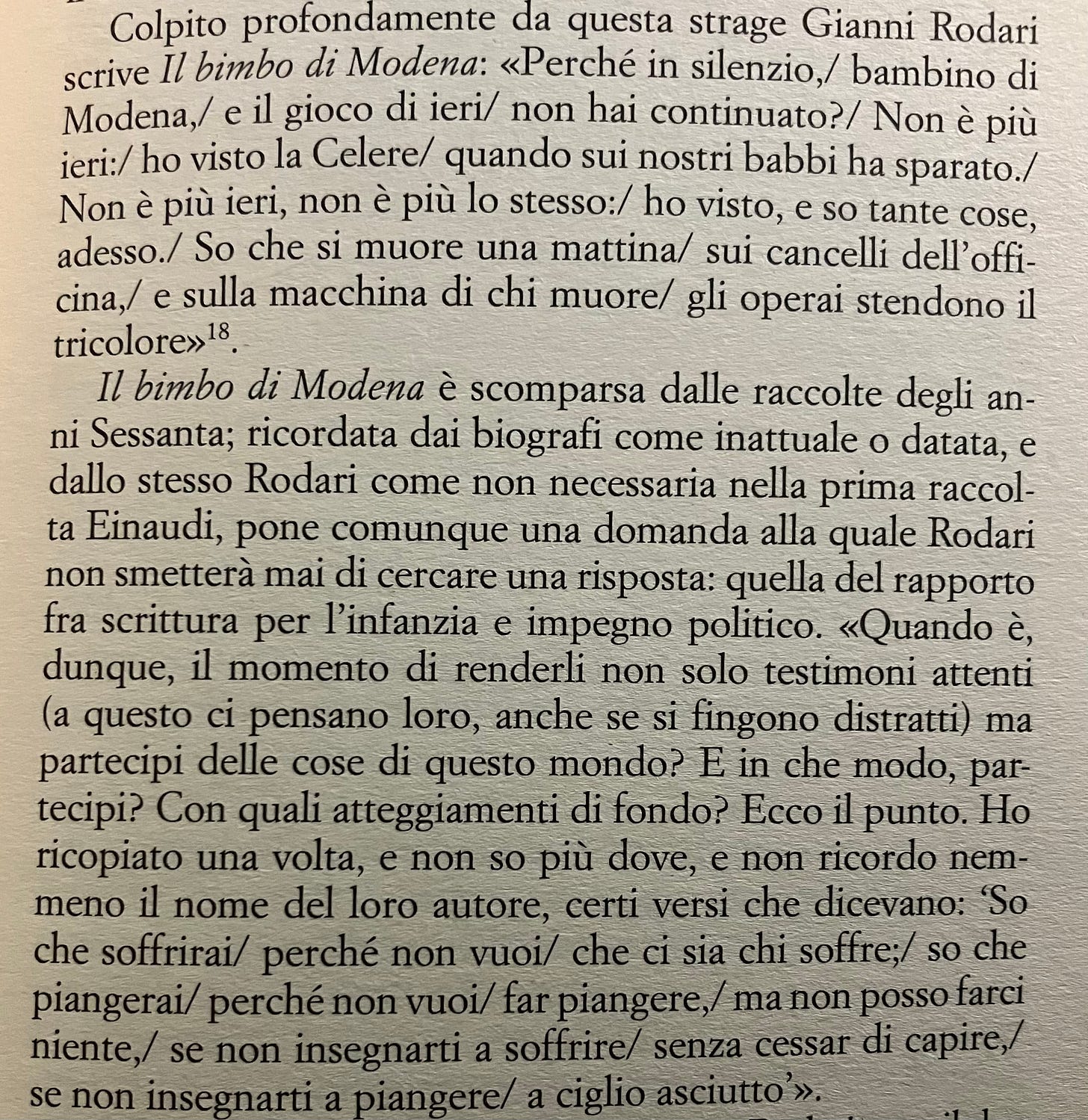#2 dietro il cielo, dietro la porta, dietro lo specchio
una soglia, una caccia, un podcast che parla di piante, una o due nonne. Tutto miscelato.
Tre anni fa mi sono iscritta di nuovo all’università. Certi giorni questa scelta mi pesa tantissimo - sono quelli in cui esco dal lavoro e vado a tirocinio, o quando mi accorgo che un laboratorio (a Scienze della Formazione Primaria quasi tutte le discipline hanno circa sedici ore di incontri laboratoriali con obbligo di frequenza) mi annoia, o è diverso da come mi aspettavo quindi mi annoia. Nel 99.9% dei casi è la stanchezza che parla: dovrei esserci abituata, visto che ho sempre studiato e lavorato insieme, ma la verità è che ci si sente sempre un po’ braccati, di corsa, quasi degli imbroglioni quando ci si dimentica di fare qualcosa o non si va a dare un esame preparati come si vorrebbe.
Altri giorni, la maggior parte dei giorni in realtà, sono contenta della mia scelta e guardo con curiosità al futuro anche tra le maglie della stanchezza. E c’è da dire che mi piace quello che faccio (altrimenti, a trent’anni, farei altro) soprattutto quando mi trovo davanti libri interessanti, che magari aggiungono altro materiale alle mie ossessioni di vecchia data, e professor* che non vogliono sentirsi ripetere la lezioncina, ma per i quali e le quali il momento dell’esame è un’occasione di confronto.
Mercoledì ho dato un esame che aspettavo dal primo anno: Letteratura per l’Infanzia.
Non è qui, non è ora, che parlerò del perché i “libri per bambini” significano così tanto per me. Oggi posso scrivere di quello che la professoressa ha chiesto a noi cinque non frequentanti, cioè di trovare una parola chiave che unisse i testi della bibliografia e di dirle cosa, tra le sue proposte, ci avesse fatto arrabbiare, anche se nel mio caso più che di rabbia parlerei di delusione.
Io ho scelto di portare la parola soglia.
L’ho scelta perché mi sono ritrovata nelle parole di molti autori, studiosi e critici della letteratura dell’infanzia che parlano di quest’età come di un momento della vita in cui il contorno tra reale e immaginato, un immaginato che non è sempre rassicurante, ma che può turbare soprattutto gli adulti, spesso è sfumato.
Scrive Maurice Sendak:
Ho un ricordo estremamente vivido della mia infanzia […] sapevo cose terribili. E sapevo che non dover far sapere agli adulti che sapevo. Si sarebbero spaventati.
Un passo e smetti di essere qui, sei Altrove, come succede ad Alice quando attraversa lo Specchio o a Pinocchio quando scappa da Geppetto e inizia la sua straordinaria avventura. Non si capisce perché questa cosa dovrebbe piacere agli adulti: i bambini, quelli veri o quelli inventati per loro dai grandi autori per l’infanzia, nascondono qualcosa e danno l’idea di sapere tutto.
Quello che l’infanzia sa, l’infanzia non dice, riprendendo il titolo di un saggio di Alison Lurie in cui l’autrice analizza alcuni capolavori per l’infanzia e individua, in ciascuno di loro, qualcosa di segreto che può essere colto solo dai bambini o dagli adulti che non hanno dimenticato cosa voglia dire infanzia.
È una questione di sensi: l’infanzia è capace di vedere oltre gli schemi che tengono stretto il mondo. Non riesce a non chiedersi cosa ci sia dietro il cielo, dietro la porta, dietro lo specchio; avverte bene che una cosa ne nasconde un’altra, che sotto il pavimento c’è un altro pavimento, dietro i volti altri volti, presagisce che non esiste assolutamente niente oltre cui non vi sia una continuità, che non c’è niente di saldo che sia veramente tale; che il visibile è minacciato da ciò che è più nascosto.
scrive Giorgia Grilli in “Di cosa parlano i libri per bambini. La letteratura per l’infanzia come critica radicale”.
Prendiamo Mary Poppins, e non la figurina edulcorata del classico Disney. La governante che arriva a casa Barks porta i bambini che le sono affidati “a passeggio”, ma in realtà queste passeggiate si rivelano viaggi fuori dall’ordinario dove oggetti inanimati prendono vita, gli animali dello zoo vivono fuori dalle gabbie (e gli umani vi sono rinchiusi) e le leggi sulla gravità non esistono. Questo può succedere perché Mary Poppins è essa stessa soglia, come la definisce Nadia Terranova - riprendendo proprio l’analisi di Grilli, nell’introduzione alla nuova edizione Rizzoli:
È la maga che conosce il creato e il fantastico, l’ordine e la bizzarria, e può muoversi con destrezza nel varco tra ciò che conosciamo e il tutto da cui veniamo. Più che una strega, Mary Poppins è una stregona: il suo potere è riconosciuto e rispettato, incuriosisce e affascina anche gli scettici. […] è soprattutto allo sciamanesimo che Mary Poppins richiama nella sua essenza.
L’infanzia, quindi è un reame delle possibilità, ma non nel senso in cui le intendiamo noi adulti. Non tutte le possibilità sono succosi frutti da raccogliere, al contrario, e il reame può essere infestato o pieno di cose che è meglio lasciarsi alle spalle.
Nel saggio “Scrivere, leggere, raccontare… La letteratura per l’infanzia tra passato e futuro” è dato un grande spazio all’abitare il margine, come ha fatto Bianca Pitzorno, dando alle ragazzine cresciute tra gli anni ‘80 e ‘90 la possibilità di confrontarsi con protagoniste femminili forti e coraggiosissime, o come fa tutt’ora Shaun Tan con le sue fiabe di periferia.
La letteratura per l’infanzia ha, difatti, un pubblico di senza voce per eccellenza ed è nelle intersezioni tra i molti modi di esserlo quando si è bambini che nascono i migliori romanzi per i più piccoli: pensiamo alla lunga carrellata di tipi strani, in viaggio, a cui manca un pezzo o più d’uno, circondati da orchi più o meno spaventosi, costretti ad attraversare boschi pericolosi - reali o immaginari che siano, che occupano le pagine dei libri per l’infanzia.
Infine: una cosa che mi ha fatto arrabbiare. O meglio, che mi ha delusa.
Tra le proposte bibliografiche ce n’era una in cui si affrontava il tema della migrazione attraverso gli albi illustrati. L’autrice propona una serie di picture books che, utilizzando la metafora del volo e delle migrazioni degli uccelli, intendono in realtà trasmettere ai bambini l’idea che tutti gli animali si spostano, e che è naturale che lo facciano anche gli esseri umani. Corretto. Ma è proprio questo “voler trasmettere” che mi lascia perplessa: siamo sicuri che i bambini abbiano bisogno di un tipo di metafora che nasce con un intento educativo? Dopotutto, non sono forse i migliori libri per l’infanzia quelli che nascono senza la pretesa di voler insegnare nulla?
I bambini sanno. Anche di migrazioni, di viaggi terribili in cui può succedere di perdere quasi tutto, e osservano quando ne parliamo proprio con lo sguardo di chi sa che di solito sotto ai buoni sentimenti ci sono le contraddizioni del mondo degli adulti.
Una lista di cose lette/fatte/viste questa settimana
A proposito di soglie: ho finito di leggere “Sotto la porta dei sussurri” di TJ Klune. Wallace Price è stato un brillante avvocato e un pessimo essere umano, è stato perché un infarto lo ha stroncato poco dopo aver licenziato l’ennesima dipendente. Quando viene portato da un Mietitore nella sala da té di Hugo, dove vivono anche il cane Apollo e l’anziano signor Nelson, ha tutta l’intenzione di dare battaglia (non solo legale) per farsi riportare indietro.
Come tutti i libri di Klune “Sotto la porta dei sussurri” ha la capacità di prenderti a schiaffi, ma con una certa tenerezza. Sono piuttosto convinta che a 13/14 anni ne avrei avuto bisogno ed è un peccato che all’epoca non esistesse niente del genere (scusami A. Chambers, ti si ama ma per altri motivi), ma adesso che di anni ne ho 30 ho comunque la possibilità di coccolare e di far sentire protetta la ragazzina che sono stata leggendoli.
Lo stesso giorno sono finalmente riuscita a concludere “I gufi dei ghiacci orientali” di Jonathan C. Slaght. Dico “finalmente” perché mentre “Sotto la porta dei sussurri” lo leggevo sul cellulare* per leggere “I gufi dei ghiacci orientali” aspettavo la sera e, a volte, mi è capitato di dare la precedenza ai libri di università. Che persona responsabile. Ho detto qualche parola qui.
*lo so che non fa bene per tutta una serie di motivi e che siamo cresciute con Rory Gilmore che si porta “Moby Dick” in autobus, però io ho 30 anni e non ci tengo a sperimentare un attacco di cervicobrachialgia solo per dimostrare pubblicamente la supremazia della carta sul digitale.Ho visto una puntata di Passato e Presente sull’Eccidio alle Fonderie Riunite.
Quello avvenuto il mattino del 9 gennaio 1950 a Modena è stato l'eccidio operaio più grave nella storia dell'Italia repubblicana: sei lavoratori uccisi a sangue freddo dalla polizia mentre manifestavano in strada. Non so perché, ma avevo l’impressione di non averne mai sentito parlare, fino a quando non hanno citato una filastrocca scritta da Gianni Rodari per la pagina domenicale, dedicata ai bambini, dell’Unità. Scrive Vanessa Roghi in “Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari”:
Siamo tornati da due settimane a scuola e tra le attività che abbiamo fatto per scaldare i motori con i due bambini del livello A1 c’è stata una caccia alle parole. Si tratta di una proposta per far conoscere meglio agli alunni neoarrivati i nomi degli oggetti della classe/scuola senza ricorrere alle schede sul quaderno (🥱) e si può svolgere in diversi modi, noi l’abbiamo giocata così: si mettono le immagini stampate sul tavolo e si corre ad appiccicarle a ciascun oggetto, poi si fa lo stesso con i cartellini delle parole, quindi si cerca di costruire delle semplici frasi.
Stiamo cercando di costruire un vocabolario della scuola, sarà più divertente quando avremo esaurito le parole della classe e si potrà fare lo stesso con gli altri ambienti (e poi immagino che andremo ad attaccare i cartellini addosso alle persone).
Per chi non lo sapesse: quest’anno il precariato mi ha fatto un dono niente male: 18 ore su Italiano L2. Non è tutto rose e fiori, dopotutto this is a gift, it comes with a price, e il prezzo da pagare è essere quel tipo di insegnante con una limitata capacità di intervento su quello che succede in classe e soprattutto su quello che accade quando non ci sono, ma stiamo lavorando bene e sento di fare una cosa per la quale sono portata.Da qualche settimana uso Fable per tenere traccia di quello che leggo. A differenza di Goodreads, che non sono mai riuscita ad utilizzare per più di qualche giorno di fila, trovo che Fable abbia una grafica molto più accattivante - cosa non si fa per l’estetica, signora mia, e che sia più semplice, e quindi più facile da aggiornare. Se lo usate anche voi mi trovate qui.
È uscito il trailer de “Il libro dell’estate”, tratto dall’omonimo libro di Tove Jansson. E io mi sono già fatta un piantino.
Botanismi è un podcast brevissimo che è un piacere ascoltare mentre si va al lavoro. Il motivo, secondo me, si trova nella descrizione che ne fa Giacomo Bagni - autore del podcast insieme a Veronica Lugaro e Sole Calbi:
Botanismi è un piccolo viaggio nel mondo vegetale, animato dal tentativo di connettere le nostre umane esperienze a tutto il verde che ci circonda e di cui spesso ci dimentichiamo, persi nelle nostre complicate vite di animali.
#UnAlboAllaSettimana
L’anno scorso, di questi tempi e su Thread, provavo a consigliare #unalboalgiorno tra quelli che di solito porto in classe. Inutile dire che quei ritmi non fanno per me, perché non sono durata neanche due mesi, ma credo che uno alla settimana sia più che sostenibile. Quindi, ecco il secondo:
Il giardino di Babushka di Jordan Scott e Sydney Smith, Orecchio Acerbo
“Il giardino di Babushka” nasce dai ricordi autobiografici di Jordan Scott sulle giornate passate “nella casa un po’ pollaio” della nonna, emigrata in Canada dalla Polonia dopo la seconda Guerra mondiale.
Babushka parla poco inglese, ma non importa: ci sono rapporti in cui c’è tanto silenzio, e non perché non si abbia niente da dire. A creare la dimensione della cura sono i gesti condivisi, quel passaggio di conoscenze tra una generazione e l’altra che contiene in sé la consapevolezza di avere qualcuno ad ascoltare ciò che non si dice, da un lato, e dall’altro la certezza di essere molto amati.
È domenica 19 gennaio 2025 e da circa una settimana il vento è feroce. Ogni tanto penso a come siano belle le città del Mediterraneo capaci di essere fredde.