#10 leggere un libro intero
educazione alla lettura, leoni in biblioteca e una cassetta degli attrezzi in aggiornamento
Alla mia prima supplenza annuale, di fronte al libro di Antologia, ho pensato che mi sarebbe piaciuto integrarlo con quello che i bambini avrebbero chiamato “il libro intero”. “Il libro intero” sarebbe stato, di volta in volta e per due anni, Il giardino segreto, Matilda, La fabbrica di Cioccolato, Marcovaldo, La Società Segreta dei Salvaparole, il primo volume della saga di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, oltre a una certa quantità di albi illustrati, almeno due alla settimana nei giorni in cui facevo il pomeriggio con loro e le ore dopo la mensa si trascinavano lente in un’aula che anche a Dicembre era calda come un forno.
Ricordo che per me il libro di Antologia era una facile via di fuga durante le ore di Italiano alle medie. Avevo provato a leggere sotto il banco, una o due volte. La professoressa P., però, aveva sviluppato in trent’anni di onorata carriera una certa abilità a sorvegliare, e quindi a punire, chiunque osasse far vagare lo sguardo fuori dal libro di testo durante i suoi monologhi. Fortunatamente, però, la sua strategia di caccia era più simile a quella di un proteo cieco che a quella di un’aquila: di fatto le bastava vedere un libro della dimensione giusta aperto sul banco e una testa china per auto-convincersi che si stesse seguendo la lezione.
Così io, di volta in volta, leggevo e rileggevo il libro di Antologia, al punto che ancora oggi se sento dire “Un giorno di gennaio” nella mia testa prendono forma le parole “Dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma”.
Funzionava un po’ come il catalogo della biblioteca: lessi degli estratti di Memorie di una ragazza per bene e de La lunga vita di Marianna Ucrìa e mi colpirono al punto che corsi a prenderli in prestito il pomeriggio stesso, al contrario capii da un passo de La casa in collina che non avrei mai letto molto di Pavese, con mio grande rammarico. Anni dopo, quando vidi in una bancarella di Trieste una copia di Padre padrone lo presi proprio spinta dal ricordo che avevo costruito grazie al mio libro di Antologia.
Da insegnanti può succedere di utilizzare la propria esperienza a scuola come punto di partenza per la progettazione. Ed è un problema. Intanto si tende a idealizzare questo o quell’altro strumento didattico, o a denigrarlo, perché nei nostri ricordi ha o non ha funzionato. Per fare un esempio banale: le schede didattiche, un oggetto che ai miei tempi era un po’ un simbolo, insieme al sussidiario, di quello che si faceva alle elementari. Farle mi piaceva, e mi piaceva soprattutto il tempo di tranquillità che era colorarle una volta completati gli esercizi. Questo, però, non significa che nel 2025 le schede didattiche siano di una qualche utilità.
Al di là del tema etico che pone distribuire in modo massiccio contenuti che spesso sono di bassa qualità (provate a cercare su Google “schede didattiche elementari” e a chiedervi se davvero non siamo in grado di inventarci di meglio per i nostri alunni e le nostre alunne) è opportuno, secondo me, domandarsi se portando in classe una risma di fogli che descrivono un perimetro così restrittivo attorno alla nostra pratica didattica non si stia, in realtà, dimenticando che la progettazione dovrebbe tenere conto delle persone che abbiamo davanti, del contesto in cui crescono, scolastico e non solo.
Quindi, se nei miei ricordi il libro di Antologia era una miniera di titoli interessanti non posso pensare che sia lo stesso per tutti. Per qualcuno, forse, può rappresentare un’occasione persa di incontro con la lettura. Ci sono case dove non ci sono libri, genitori che non hanno gli strumenti per offrire ai propri figli proposte di qualità, e altri che pensano alla lettura non come a qualsiasi altro passatempo, ma come a un qualcosa di alternativo, quindi di migliore: “Leggi qualche pagina, invece di…”.
Quello che succede a casa, però, mi interessa fino a un certo punto e solo come metro per stabilire dove comincia il mio lavoro educativo. Sentenziare “I miei alunni non leggono” e non fare niente per intervenire, soprattutto alla scuola primaria, significa certificare le differenze nelle opportunità di partenza che questi bambini e bambine hanno avuto e lasciare tutto così com’è.
Per questo, secondo me, a scuola si devono leggere anche libri interi creando un’ambiente educativo che li faccia percepire ai bambini come una presenza quotidiana, familiare, desiderabile.
Per farlo è molto importante che sia l’adulto a leggere ad alta voce, costruendo un rituale condiviso dentro il tempo scuola. Dopotutto per leggere serve tempo: tempo per ascoltare una storia, per stare dentro le parole, per scegliere senza fretta e senza che la lettura sia legata a una prestazione, a un voto.
Le ricerche sugli effetti della lettura ad alta voce nelle scuole parlano chiaro: leggere ai bambini e alle bambine ogni giorno, senza pretendere subito una restituzione, migliora il lessico, le competenze di comprensione, la capacità di concentrazione, perfino l'autoefficacia scolastica. In questo senso, la qualità delle proposte è fondamentale e, di nuovo, diventa centrale conoscere chi abbiamo davanti, accettando di procedere per prove ed errori.
Tra Il barone rampante e la mia vecchia quinta, per esempio, non ha funzionato.
Ha funzionato, invece, e a molti è piaciuto molto di più di Matilda che abbiamo letto lo stesso anno, Il giardino segreto. Mi sarebbe piaciuto condividere con loro la lettura di uno dei miei romanzi preferiti di sempre? Certo. Ma, di nuovo: non sono io o la Martina bambina la destinataria delle mie proposte.
In effetti, con la lettura ad alta voce, il singolo sfuma nel collettivo molto più che in altre pratiche scolastiche: alla fine, certi giorni, ci si accorge che c’è solo un gruppo di persone che si godono una bella storia, insieme.
Compiti a casa
per il/la tuo/a bambino/a interiore
Nel posto in cui vivi c’è una libreria per bambini? Se la risposta è sì allora potresti dedicare un pomeriggio ad esplorarla. Potresti scoprire cose sorprendenti e, chissà, uscire da lì con un libro tutto per te.
Per aiutarti nella tua ricerca condivido con te questa lista di Roberta Favia che raccoglie le librerie per bambini e ragazzi in tutta Italia.
Se invece non esistono librerie specializzate nel posto in cui abiti puoi sempre andare in biblioteca o in un’altra libreria che sicuramente ha delle sezioni dedicate ai lettori 0-6 e 6-11.
I miei posti del cuore a Genova sono la Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo de Amicis, la Biblioteca Kora e la libreria L’amico immaginario, spin off per bambini e ragazzi della mia libreria indipendente preferita “per grandi”.
Quando vivevo a Milano, invece, il mio punto di riferimento era Spazio BK.
Un albo alla settimana
Un leone in biblioteca di Michel Knudsen e Kevin Hawkes
Tra i tanti libri capaci di raccontare cosa può diventare una biblioteca, Un leone in biblioteca di Michelle Knudsen e Kevin Hawkes è una piccola gemma. Inizia con un’improbabile visita: un leone entra in una biblioteca pubblica. Non aggredisce nessuno, non rompe nulla, ma si muove tra gli scaffali con curiosità, si accoccola nell’angolo morbido, ascolta l’ora del racconto con grande attenzione. Nessuna regola vieta esplicitamente la presenza di un leone, perciò la bibliotecaria, la signora Brontolini, gli permette di restare, anche perché ben presto il leone si rivela essere un aiutante prezioso: aiuta i bambini a raggiungere i libri in alto, lecca le buste per le restituzioni, spolvera gli scaffali con la coda. Fino a che, per aiutare in un momento di emergenza, ruggisce. E viene cacciato: ha infranto la regola del silenzio. Ma proprio quel ruggito diventa occasione per rivedere le norme e ripensare il ruolo di chi abita, e ama, la biblioteca.
Miscele
Questa settimana, visto il tema della newsletter, ho pensato di proporvi una lista di punti di riferimento che mi sono costruita negli anni sui temi della letteratura per l’infanzia e della lettura ad alta voce. Sentitevi liberi di contribuire con altri titoli rispondendo a questa mail o scrivendomi in dm su Instagram.
Giorgia Grilli, Di cosa parlano i libri per bambini, Donzelli Editore
Federico Batini, La lettura ad alta voce condivisa, Il Mulino
Alice Bigli, Leggere piano, forte, fortissimo, Mondadori
Aidan Chambers, Il lettore infinito, Equilibri
Aidan Chambers, Siamo quello che leggiamo, Equilibri
Pino Boero e Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia, Editori Laterza
Paola Vassalli, ABC delle figure nei libri per ragazzi, Donzelli Editore
Antonella Capetti, A scuola con gli albi, Topipittori
Frank Serafini e Suzette Serafini-Young, Leggere giorno per giorno, Equilibri
Silvia Vecchini, Una frescura al centro del petto, Topipittori
Maria Polita, 101 libri da leggere prima dei sette anni, Solferino
Leggimi ancora, progetto di Giunti Scuola per la diffusione della lettura ad alta voce
Per leggere il mondo, corso dell’Associazione Literacy Italia con le case editrici Babalibri ed Equilibri sull’educazione alla lettura
Liber, trimestrale di informazione bibliografica a orientamento critico sulla letteratura e la narrativa per l’infanzia
Andersen, mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale dell’infanzia
IBBY - International Board on Books for Young People, é un’organizzazione internazionale no-profit nata con lo scopo di facilitare l’incontro tra libri, bambini e bambine e ragazzi e ragazze.
Nati per leggere, è un programma sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Propone attività di educazione alla lettura per bambini fino ai 6 anni.
LaAV - Letture ad Alta Voce, è una rete di volontari e volontarie nata all’interno dell’associazione Nausika per promuovere il valore della lettura come strumento efficace e alla portata di tutti. Esistono, oltre ai circoli per adulti che fanno volontariato nelle biblioteche o negli ospedali, anche gruppi denominati TeenLaAV che vanno dai sette ai diciassette anni e che si incontrano per leggere tra loro e per gli altri.
È domenica 27 Aprile e, da ieri, ho una bellissima pressa per fiori con sopra una mandragora disegnata col pirografo. Non vedo l’ora di usarla.
Spazio auto-promozione
Tutto quello che pubblico sui social e quello che scrivo in questa newsletter è frutto di ricerche personali e indipendenti. Se vuoi supportare quello che faccio ricordati di interagire con i miei contenuti lasciando un commento o condividendoli sui tuoi profili e pagine personali.
Grazie! 💌
Ho pensato che potesse essere interessante vedere gli albi della settimana di questa newsletter sfogliati, anche per capire meglio il formato e come vengono distribuite illustrazioni e parole nella pagina (per me fondamentale se voglio regalarlo a un bambino o a una bambina).
Qui trovate il reel sull’albo della settimana scorsa, “Quattordici lupi” di Catherine Barr e Jenni Desmond, pubblicato da Editoriale Scienza:
Il trend #booksthatmademe è, secondo me, uno dei più carini di quest’anno (insieme a quello con le evoluzioni dei Pokémon). Potevo forse esimermi?
Qui trovate il video con i 30+1 libri che mi hanno formata nei miei primi 31 anni di vita:
Hai perso gli ultimi numeri di questa newsletter? Li puoi leggere qui:

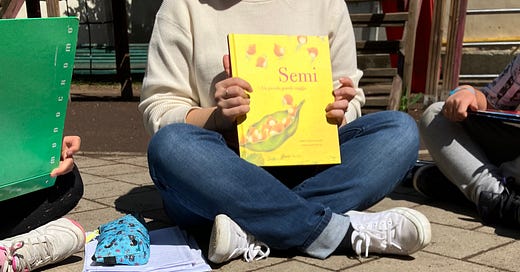








Sono curiosa del come mai, secondo te, non sia andata con il barone rampante: anche io lo avrei messo fra le prime scelte, oh la sinforoosaaa!
Proprio l'altro giorno, camminando a zonzo, ho trovato una libreria solo per bambini che non conoscevo, in una via un po' defilata fuori dal centro. Era chiusa ma con una vetrina che faceva gola.
Commentando in ritardo, allego qui anche un progettino nuovo: Comics&Science, una collana a fumetti che parla di scienza, sta lanciando uno speciale infanzia https://www.comicsandscience.it/al-salone-del-libro-lanteprima-di-comicsscience-kiz/
Cara Martina, che bella questa bella puntata! Proprio ieri stavo parlando con mia figlia (appassionata lettrice dodicenne) del perché non le piacesse il libro che stavano leggendo in classe. È venuto fuori che in verità la storia la interessava, quello che non sopporta è di dover fare un riassunto di ogni capitolo, di dover rispondere a domande tipo "Cosa ha fatto il protagonista XY?" "Perchè la personaggia AB si è comportata così?". Penso che il disagio nasca dal sentirsi controllata nella lettura, doverne rendere conto. Senza nulla voler togliere all'insegnante, che ha scelto un libro interessante e di cui capisco in parte le motivazioni, è un peccato che non si riescano a trovare altri modi per esercitare la comprensione del testo e la scrittura.
Grazie anche per la preziosissima liste di risorse!